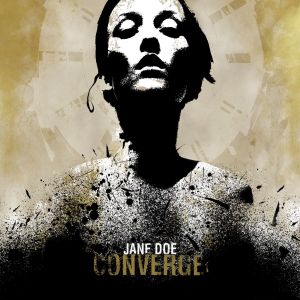Dalla sua definizione e affermazione negli anni ’50 il rock ha accompagnato la società occidentale contribuendo a definire stati d’animo universali. Parlando di arte più in generale è opportuno riflettere su come essa abbia continuato a oscillare fra il concetto di mezzo (attraverso cui esprimere le emozioni) e fine (fine a sè stessa). Arte come mezzo presuppone un contenuto, arte come fine presuppone una forma.
Dalla sua definizione e affermazione negli anni ’50 il rock ha accompagnato la società occidentale contribuendo a definire stati d’animo universali. Parlando di arte più in generale è opportuno riflettere su come essa abbia continuato a oscillare fra il concetto di mezzo (attraverso cui esprimere le emozioni) e fine (fine a sè stessa). Arte come mezzo presuppone un contenuto, arte come fine presuppone una forma.
Nel rock la prima distinzione fra musicisti indipendenti e non riguarda sia la forma (suoni grezzi i primi, suoni raffinati i secondi) sia il contenuto (solitamente presente nei primi, assente nei secondi). Non c’è molto da dire sulla forma: la perfezione formale è una chimera inseguita sia da grandi esteti (Brian Wilson, i Beatles, Phil Spector) che da sostanziali incompetenti che sono stati dimenticati. Ad ogni modo la perfezione formale ha sempre presupposto tecnologie e mezzi economici. Au contraire, il contenuto non dipende da tecnologie e mezzi economici, ma dalla sensibilità dei musicisti. Una volta tracciato il formato (che tuttavia molti non interessati al profitto hanno stravolto) il contenuto conquistò il ruolo di protagonista concettuale come il richiamo generazionale di Chuck Berry, la rivoluzione metafisica dei Doors, l’esistenzialismo dei Velvet Underground, le predicazioni di Dylan. E ancora il nichilismo dei punk, l’alienazione industriale della new wave, l’intimismo degli Smiths. La forma tuttavia continuò ad essere la direzione fondamentale delle major e dei musicisti di successo, la maggior parte dei quali sono considerati (alcuni a ragione, molti altri a torto) fra i più importanti della storia del rock, grazie alle vendite record e alla loro sensazionale popolarità fra le masse. (“Le classifiche come criterio di giudizio: Billboard“)
Ogni epoca ha i propri musicisti di successo, che compiono i loro percorsi formali; gli ultimi 15 anni hanno visto i Radiohead come protagonisti. La band inglese gode di notorietà e stima, mettendo d’accordo pubblico e critica: i Radiohead risultano il gruppo più ascoltato fra gli utenti del social network Last.fm (più di Beatles e Lady Gaga) e le riviste di settore abbondano di articoli che elogiano la squisitezza delle loro produzioni, abbandonandosi in divagazioni sull’alienazione, uno dei temi più esplorati non solo nel rock ma nell’arte in generale.
Per quanto ne dicano, i Radiohead sono essenzialmente un gruppo sopravvalutato: i loro artifici di produzione snaturano l’essenza del rock e vanno a colmare il vuoto causato dall’assenza di contenuti. In termini strettamente musicali e formali sono molto meno innovativi di quanto non venga detto.
La band nasce nel 1985 e dopo la gavetta ottiene un contratto con la EMI che decide anche di cambiarne il nome. Radiohead fu infatti suggerito dall’etichetta basandosi su una traccia dei Talking Heads. Nel 1993 viene pubblicato Pablo Honey, il primo album, seguito, nel 1995, da The Bends. Questi due album non sono altro che una raccolta di stereotipi brit-pop che fanno sorridere i fan degli Smiths; due album di qualità ma che non dicono nulla di nuovo: i Radiohead si avventurano nella poetica di Morrissey senza farla propria e rileggendola con un che di spiazzante infantilismo; due album prodotti fondamentalmente per vendere e permettere alla band di entrare a far parte del fenomeno discografico di quegli anni, capeggiato da Blur e Oasis. Oltre la raffinatezza di arrangiamenti e sonorità non c’è molto da dire. Sfruttando i produttori di Pixies e Dinosaur Jr per il primo album e il produttore degli Stone Roses per il secondo, ottennero quel sound “alternativo” che dopo l’esplosione di Nevermind dei Nirvana sembrava l’unico modo per ottenere successo. Si potrebbe addirittura insinuare che la scelta di John Leckie (produttore degli Stone Roses) come produttore fosse stata dettata dalla necessità di ottenere successo nel Regno Unito. Missione compiuta.
Con Ok Computer (1997) i Radiohead raggiungono il vertice della loro carriera. L’album è un successo mondiale e la stampa li saluta come uno dei gruppi più importanti della storia. Il peso di queste recensioni sulla seconda parte della carriera della band è in un certo senso maggiore dell’importanza degli Smiths per quanto riguarda la prima. Ok Computer è uno spartiacque: prima di questo disco i Radiohead erano un normale gruppo brit-pop oscurato dall’ombra di Oasis e Blur; senza i Radiohead avrebbero probabilmente fatto la fine di Pulp e Suede (che nulla hanno da invidiare ai Radiohead, anzi) ovvero l’anticamera del dimenticatoio; dopo Ok Computer i membri della band si calano nel ruolo di intellettuali, il pubblico li considera geniali ed innovativi e il loro stile muta profondamente.
 Non si capisce bene cosa abbia portato al loro cambio stilistico, semplicemente in alcune interviste i membri del gruppo parlano di voler far qualcosa di nuovo e di diverso. Possiamo credere ai Radiohead o possiamo pensare al contesto in cui la scelta di “fare qualcosa di diverso” è stata maturata: nel 1995 la stampa inglese rievoca la rivalità fra Beatles e Rolling Stones iniziando a parlare di “guerra del brit-pop” fra Oasis e Blur, semplicemente per farne discutere e pubblicizzarli; l’uscita quasi in contemporanea di What’s the Story (Morning Glory) dei primi e The Great Escape dei secondi è lo scontro finale. Il risultato di questa irreale sfida (in realtà gli Oasis ci credevano davvero, poverini) è ovviamente misurato dalle riviste di settore in termini di vendite e non in termini qualitativi; fatto sta che gli Oasis sbaragliano la concorrenza (con un album che è praticamente uguale dall’inizio alla fine) e vincono il trofeo di sovrani del brit-pop. La carriera degli Oasis finisce in quell’istante, l’album successivo non ottiene il successo sperato e le cose si metteranno sempre peggio, dicono quel poco che avevano da dire e decidono di non abbandonare mai il glorioso 1995. I Blur invece, migliori in quasi tutto, optano per un drastico cambio di direzione, scappando da quel genere che le major e le riviste avevano ormai reso una pagliacciata. Probabilmente i Blur ci avevano pensato prima della pubblicazione di The Great Escape: il titolo parla chiaro, Charmless Man parla chiaro e sono tanti gli indizi. Purtroppo anche i Blur finiscono nel ’95, ma non per demeriti musicali: droga e alcohol sfaldano l’alchimia del gruppo tenuto insieme dal solo Damon Albarn. La decisione dei Blur di abbandonare la scena brit-pop spiega la “coraggiosa” scelta dei Radiohead di cambiare direzione, il lento e inesorabile declino degli Oasis la giustifica.
Non si capisce bene cosa abbia portato al loro cambio stilistico, semplicemente in alcune interviste i membri del gruppo parlano di voler far qualcosa di nuovo e di diverso. Possiamo credere ai Radiohead o possiamo pensare al contesto in cui la scelta di “fare qualcosa di diverso” è stata maturata: nel 1995 la stampa inglese rievoca la rivalità fra Beatles e Rolling Stones iniziando a parlare di “guerra del brit-pop” fra Oasis e Blur, semplicemente per farne discutere e pubblicizzarli; l’uscita quasi in contemporanea di What’s the Story (Morning Glory) dei primi e The Great Escape dei secondi è lo scontro finale. Il risultato di questa irreale sfida (in realtà gli Oasis ci credevano davvero, poverini) è ovviamente misurato dalle riviste di settore in termini di vendite e non in termini qualitativi; fatto sta che gli Oasis sbaragliano la concorrenza (con un album che è praticamente uguale dall’inizio alla fine) e vincono il trofeo di sovrani del brit-pop. La carriera degli Oasis finisce in quell’istante, l’album successivo non ottiene il successo sperato e le cose si metteranno sempre peggio, dicono quel poco che avevano da dire e decidono di non abbandonare mai il glorioso 1995. I Blur invece, migliori in quasi tutto, optano per un drastico cambio di direzione, scappando da quel genere che le major e le riviste avevano ormai reso una pagliacciata. Probabilmente i Blur ci avevano pensato prima della pubblicazione di The Great Escape: il titolo parla chiaro, Charmless Man parla chiaro e sono tanti gli indizi. Purtroppo anche i Blur finiscono nel ’95, ma non per demeriti musicali: droga e alcohol sfaldano l’alchimia del gruppo tenuto insieme dal solo Damon Albarn. La decisione dei Blur di abbandonare la scena brit-pop spiega la “coraggiosa” scelta dei Radiohead di cambiare direzione, il lento e inesorabile declino degli Oasis la giustifica.
E’ inutile e fuori luogo che Yorke e compagni si sprechino in discorsi sull’alienazione moderna (una sorta di concezione alla Devo, che sono venuti 20 anni prima, filtrata dalla malinconia degli onnipresenti Smiths, che sono venuti 15 anni prima); Ok Computer non aggiunge nulla a quel grande discorso che è il rock, non ne rivoluziona la comunicazione. Ok Computer rinnova le tecniche di produzione musicale, così come Abbey Road (Beatles), Pet Sounds (Beach Boys), The Dark Side of the Moon (Pink Floyd) e Thriller (Michael Jackson) hanno fatto in passato. L’album è stato più o meno autoprodotto, e questo è senz’altro un merito. I Radiohead e i loro tecnici dimostrano di possedere un orecchio eccellente (come Brian Wilson dei Beach Boys all’incirca); peccato che il rock non si tratti di questo.
Come anticipato, Ok Computer cala i Radiohead nel ruolo di grandi innovatori (le grandi innovazioni non le ho ancora identificate) e forti del loro successo si danno alla musica sperimentale, o meglio, dal pop passano al pop sperimentale, uno stile di musica melodica e per le masse spacciato per alto e intellettuale. Il gruppo non si ferma a Karma Police (una delle loro canzoni più di successo) ma decidono di continuare a rinnovare; per fare questo guardano indietro di trent’anni, raccogliendo spunti dal rock tedesco degli anni ’70, dal progressive e da Miles Davis. Esce prima Kid A (sperimentazioni affiancate a canzoni pop pure per non suicidarsi commercialmente) e poi Amnesiac (l’esperimento di Kid A è andato bene, i Radiohead fanno un album gemello, questa volta interamente “experimental pop”).
 Questi due album sono quanto di più artificiale e costruito il rock abbia mai visto. I Radiohead vanno ben oltre i pomposi archi degli ultimi Beatles (Let it be, prodotto da Phil Spector). Il risultato è un suono completamente elettronico, tutto è filtrato dai computer (persino la voce), il contenuto conta sempre meno (non si può neanche più parlare di alienazione moderna) a vantaggio di una forma tradizionalissima ma semplicemente super elettronica. I Radiohead guardano di qua e di là in cerca di spunti avanguardistici e alternativi. Arrivano a plagiare gruppi underground americani che avevano fatto le stesse cose con più sentimento e meno mezzi tecnologici (confrontate “The National Anthem” con “Good” dei Morphine una band di Boston attiva dai primi anni ’90).
Questi due album sono quanto di più artificiale e costruito il rock abbia mai visto. I Radiohead vanno ben oltre i pomposi archi degli ultimi Beatles (Let it be, prodotto da Phil Spector). Il risultato è un suono completamente elettronico, tutto è filtrato dai computer (persino la voce), il contenuto conta sempre meno (non si può neanche più parlare di alienazione moderna) a vantaggio di una forma tradizionalissima ma semplicemente super elettronica. I Radiohead guardano di qua e di là in cerca di spunti avanguardistici e alternativi. Arrivano a plagiare gruppi underground americani che avevano fatto le stesse cose con più sentimento e meno mezzi tecnologici (confrontate “The National Anthem” con “Good” dei Morphine una band di Boston attiva dai primi anni ’90).
Dopo Amnesiac anche i Radiohead si fermano e stazionano. Pubblicano album ogni tanto, si guadagnano il rispetto dei fan attraverso il web (album scaricabili gratis). Quando uscì In Rainbows, nel 2007, i Radiohead facevano parlare di sè più per il modo in cui facevano le cose (l’album lo paghi quanto vuoi, su internet) che per il risultato musicale. Anni di pubblicità promossa dalla EMI assicurò il successo commerciale di un album non solo povero di contenuti, ma anche noioso e ripetitivo.
Le teorie sulla grande importanza dei Radiohead e sulle loro strabilianti rivoluzioni non hanno nulla di fondato. Yorke e colleghi non possono ispirare nessun gruppo rock, semplicemente per il fatto che non sono imitabili da nessuno per via della loro artificiosità. Il loro ruolo e i loro meriti verranno fortemente ridimensionati nel tempo. Oggi sono pochi i gruppi ispirati dai Radiohead, ma ciò che più dovrebbe far riflettere è la pessima qualità della musica che questi gruppi suonano: Coldplay e Muse. A contrario dei Radiohead queste due band non meritano neppure un’analisi.L’artificiosità dei Radiohead è stata più dannosa che altro. I loro meriti vanno fortemente ridimensionati, soprattutto in virtù di cosa usciva nell’underground nel 1997 (l’anno di Ok Computer), di cosa c’è stato sia in Inghilterra che negli Usa negli anni 2000 e di cosa, anche per colpa dei Radiohead, ci siamo persi in questi ultimi anni.
A.M.